

Giorgio Nacci, presbitero dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, è docente incaricato di Teologia morale fondamentale presso l’Istituto Teologico Regina Apuliae (Molfetta) della Facoltà Teologica Pugliese (Bari). Oltre a diversi articoli scientifici, è autore di due volumi in corso di pubblicazione: Uomini di discernimento. Formare presbiteri accompagnatori nel discernimento morale EMP (2025); Scelgo il bene! Educazione morale ed iniziazione cristiana (a cura), EMP (2025).
«La società civile vive oggi in un crocevia di sistemi etici, tanto teorici quanto pratici. Invece di rigettarli a priori i cristiani dovranno dialogare con essi, se devono vivere in mezzo al mondo. A volte possono avere la sensazione di aver perso improvvisamente la loro pretesa esclusività nel campo dell’etica. Questa situazione di crisi, però, non può convertirsi in motivo di fuga e scoraggiamento. In questa nuova situazione si presenta la necessità […] di stabilire le basi per un nuovo dialogo»[1]. L’urgenza del dialogo, individuata in questo testo da José-Romàn Flecha, sembra indicare una direzione di metodo per rispondere alla domanda dello studente Tommaso Fucci. Un dialogo che, secondo Antonio G. Fidalgo, chiede all’ethos cristiano di riconfigurarsi in ogni epoca storica per essere fedele alla legge dinamica dell’incarnazione. Al centro di questo processo, per il teologo argentino, più che la persona di Cristo in quanto tale, c’è la rivelazione del «suo progetto universale di una nuova umanità», configurata «come spazio e realizzazione di una “fraternità/sororità universale” a tutti i livelli, personale, sociale, strutturale e sistemico». Nel modo in cui si relazionano con gli altri i credenti possono far emergere la specificità dell’etica cristiana senza per forza indicare cosa si deve fare o cosa non si deve fare, ma vivendo in modo rinnovato le relazioni.
Senza perdere di vista tale realtà fraterna/comunionale, vorrei provare ad approfondire come l’ethos determinato da questa realtà affondi le radici nel progetto di Dio sull’uomo e sulla donna rivelato nell’umanità di Cristo. Egli è il modello dell’umanità nuova perché «nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo», svelando «pienamente l’uomo a se stesso» (Gaudium et spes, 22). In un mondo pluralista e complesso, la sfida dell’etica teologica consiste proprio nel rendere l’umanità il terreno sul quale può avvenire un dialogo rispettoso e profondo, volto al riconoscimento dei valori comuni. Questa affermazione, a mio avviso, porta con sé tre pilastri sul quale questo dialogo può reggersi.
Primo pilastro: la reciprocità nel riconoscimento dei valori etici
La logica sottesa all’incarnazione chiede all’etica di operare un processo di condivisione dell’esperienza umana che impone una sorta di “deconfessionalizzazione” grazie alla quale abbandonare l’idea di una superiorità tout court dell’etica cristiana in quanto tale, per presentarla, con prudenza e carità, come una proposta etica della pienezza di vita, di umanità (cf. Nostra aetate, 2). Per fare questo, senza svilire la preziosità del messaggio del vangelo e senza rinunciare ad un annuncio esplicito, i credenti devono imparare ad intercettare i valori etici che si incontrano in altre culture o religioni proprio a partire dall’esperienza umana. Troppe volte, invece, l’etica diviene terreno di scontro più che di incontro. Fuori da logiche di recinti e di contrapposizioni, anche nel campo morale la comunità dei credenti non ha solo qualcosa da dire, ma può avere anche qualcosa da imparare. Basti pensare al cammino fatto per dichiarare la pena di morte moralmente illecita. La nuova redazione del testo del Catechismo della Chiesa Cattolica ammette che questa scelta è frutto del riconoscimento di un valore molto presente nella nostra cultura, quello della dignità della persona, la quale non si perde neanche dopo aver commesso crimini gravissimi (cf. CCC, 2267). In questa prospettiva, l’ethos cristiano non può essere proposto contro qualcuno, ma in relazione a qualcuno: da questa reciprocità possono venire risposte nuove a problemi nuovi. L’ascolto dell’esperienza umana, nella varietà delle culture e delle esperienze religiose con cui essa si esprime, è davvero un passo importante per avviare un dialogo costruttivo sui temi etici.
Secondo pilastro: un modello condiviso di persona umana
Gesù costituisce un modello di umanità per l’uomo e la donna di ogni epoca, per quanto inarrivabile a motivo della sua singolarità. Da lui prende avvio la trasformazione dell’uomo interiore verso la pienezza di vita, la quale si compirà in modo pieno alla fine dei tempi. In questo tempo, noi viviamo un cammino graduale di conformazione alla sua umanità, in un itinerario storicamente determinato. Proprio questo è lo spazio nel quale ci si può interrogare su cosa è realmente umano e su quale modello di persona umana fonda le diverse riflessioni etiche. Su questo campo l’etica teologica, senza rinunciare a far valere la verità oggettiva sull’uomo e sulla donna così come emerge dalla Rivelazione, deve superare un’antropologia frutto esclusivamente di un deduttivismo metafisico. Se vogliamo lavorare per costruire un modello antropologico condiviso sul quale fondare una proposta etica, non possiamo non accogliere con favore i dati delle scienze sociali ed economiche, della medicina, delle scienze umane, delle neuroscienze. La stessa comprensione della persona umana alla luce della Rivelazione non può avvenire in maniera totalmente indipendente da quanto oggi questi dati ci consegnano. Del resto, il deduttivismo metafisico ha sempre utilizzato precise categorie filosofiche e culturali con le quali descrivere l’humanum; oggi queste categorie possono arricchirsi con quanto ci fanno conoscere le scienze. Come possiamo parlare ed indicare un modello etico, infatti, di sessualità, di bioetica, di libertà, di maschile-femminile, senza conoscere e, in taluni casi, appropriarci di quanto ci dicono le scienze su questi temi? Non è forse questo un elemento essenziale per mettersi in dialogo con le diverse antropologie oggi presenti nella nostra società – anche solo in relazione all’uso di un linguaggio universale e comprensibile da tutti – pur conservando lo specifico di un’antropologia rivelata? La logica dell’incarnazione ci chiede di costruire una visione di persona umana integrando una visione antropologica dall’alto con una dal basso.
Terzo pilastro: un’umanità che si fa dono
Ma la vera novità dell’ethos cristiano sta nel riconoscere che la pienezza di vita ricercata dall’uomo e dalla donna di ogni tempo, risiede nel dono di sé: è questo il principio etico per eccellenza al quale dobbiamo conformarci. Qui si comprende cosa significa considerare l’umanità di Cristo modello di ogni umanità. La sua pro-esistenza è l’anelito di bene presente in tutti, indipendentemente dalle culture, dalle religioni, dai contesti geo-politici. Guardare a lui significa vivere anche la nostra pro-esistenza. È su questo che ci giochiamo la credibilità di una proposta etica cristiana; ed è spesso su questo piano che veniamo riconosciuti fragili, perciò non incisivi. In un mondo autocentrato, dove sembra smarrirsi il senso del bene comune a favore di una sterile autoreferenzialità, dove l’altro è visto sempre più come una minaccia e dove la violenza sembra quasi l’unica risposta ad ogni forma di differenza, i cristiani sono chiamati a mostrare la portata di umanità custodita nell’accoglienza, nella tolleranza, nell’inclusione, nella ricerca di ciò che rende migliore la vita di tutti, non solo di qualcuno. Non possono essere questi i principali valori su cui oggi, l’ehtos cristiano, mostra il suo singolare contributo alla ricerca e alla scelta del bene nel nostro tempo?
C’è un rischio però a cui in questo periodo della storia dobbiamo guardare con molta attenzione: quello che l’etica cristiana – in particolare quella cattolica – diventi un paravento dei poteri forti per affermare il loro predominio. Di qui l’impegno della comunità cristiana a proporre un’etica calibrata sulla ricerca e realizzazione di una umanità vera, contro ogni forma di disumanizzazione, individuale, sociale e istituzionale, in un dialogo saggio e proficuo con i diversi modelli etici oggi presenti. Nella certezza che solo ciò che è profondamente umano, è autenticamente cristiano.
[1] J.-R. Flecha, La vita nuova in Cristo. Fondamenti della morale cristiana, EMP, Padova 2002, 129.
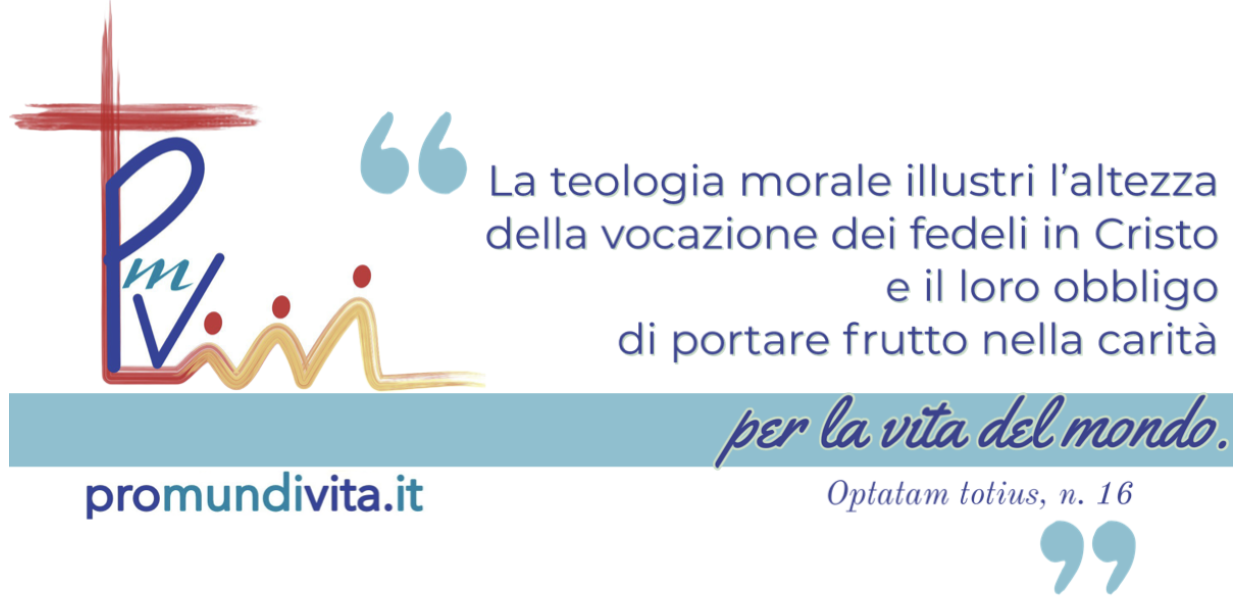




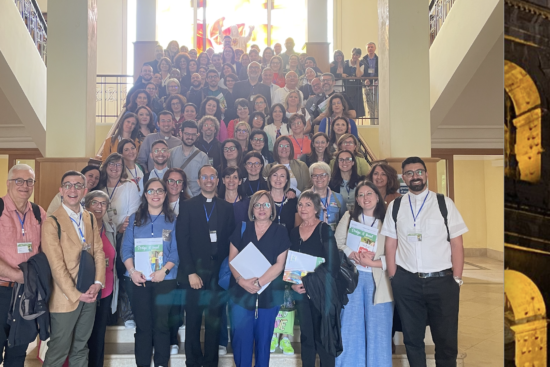

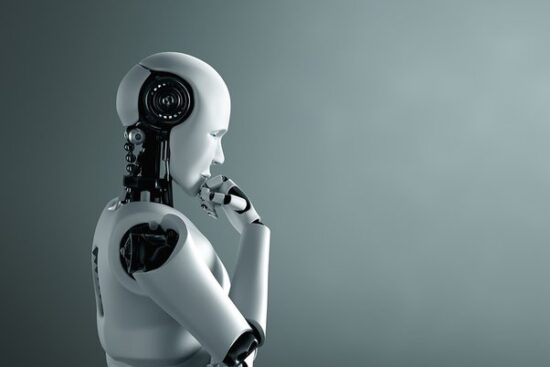
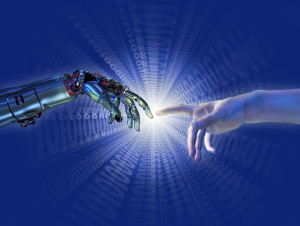

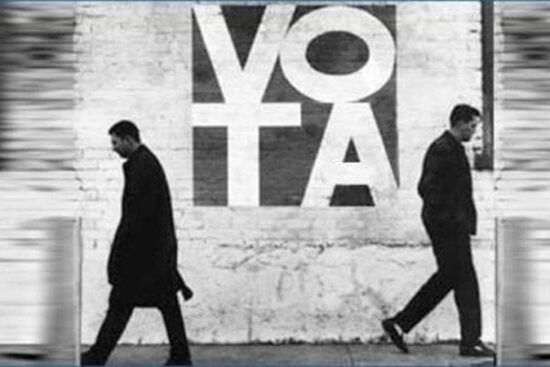


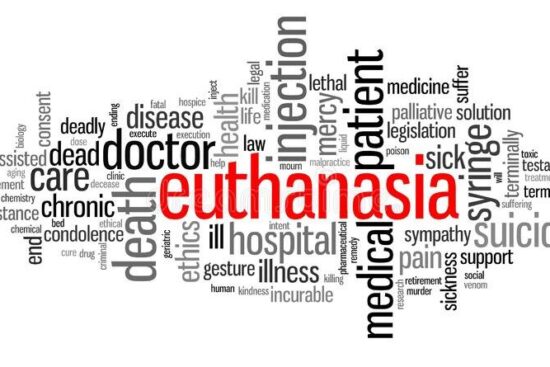

Lascia un commento