
Dopo l’intervento principale del professor Fidalgo e la prima risposta del professor Giorgio Nacci, conclude questo approfondimento sulla domanda di Tommaso Fucci il post del professor Cataldo Zuccaro. Presbitero della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, è docente emerito di teologia morale nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Urbaniana di Roma, dove ha ricoperto anche l’incarico di decano e di rettore. È professore invitato presso il Pontificio Istituto Accademia Alfonsiana di Roma. Sul tema in analisi ha scritto il testo Cristologia e morale. Storia, interpretazione, prospettive, EDB, Bologna 2003.

Nell’ambito della riflessione morale, l’ethos si potrebbe intendere come l’insieme delle norme e dei costumi morali tacitamente condivisi e accettati all’interno di una particolare società o di una comunità. Sulla base di questo insieme di evidenze morali, normalmente i membri della comunità regolano i loro rapporti e operano le loro scelte personali e comunitarie, perché l’esperienza li ha convinti della validità di quel kit di pronto intervento morale rappresentato dall’ethos vigente. Va da sé che esistono diversi ethos comunitari, cioè diverse consuetudini e costumi morali che stanno alla base della cultura vissuta concretamente da società diverse o anche da fedeli che si riconoscono in diverse tradizioni religiose. È anche utile ricordare che le persone mantengono sostanzialmente la libertà di coscienza di agire in modo diverso dalla maggioranza, soprattutto nel caso in cui percepissero alcune consuetudini morali contrarie a ciò che esse ritengono giusto.
È intuitivo pensare che l’ethos africano non sia lo stesso di quello asiatico o di quello europeo, sebbene all’interno di ciascun raggruppamento geografico e antropologico esistano una serie di costumi e tradizioni morali in parte simili. Ciò che assicura il successo di un ethos particolare non è la semplice regola, scritta o meno, ma il fatto che esso è il riflesso di un insieme di valori umani che le persone sperimentano come importanti sulla base di una scala gerarchica funzionale allo svolgimento ordinato della loro vita. Quando, però, cominciassero a constatare che quei valori non rispondono più allo scopo desiderato, allora anche l’ethos, fino ad allora vigente, comincerebbe a diventare obsoleto, aprendo lo spazio alla formazione di nuovi modelli di comportamento.
L’ethos cristiano non sfugge alle dinamiche descritte, che riguardano il rapporto tra il modo di vivere e il riferimento ai valori di fondo che lo ispira. Anzi, stando alla testimonianza del Nuovo Testamento, soprattutto delle Lettere di S. Paolo, la connessione tra l’accoglienza di Cristo nella fede e la vita nuova che ne deriva è talmente forte che le esigenze morali, espresse in quel particolare ethos storico, entrano a far parte dello stesso kerigma, cioè dell’annuncio essenziale e irrinunciabile del mistero di Cristo. Pertanto, se è vero che senza un ethos corrispondente l’annuncio di Cristo sarebbe incompleto, è anche vero che senza il riferimento a Cristo l’ethos cristiano sarebbe privato del suo fondamento e si ridurrebbe ad un insieme di usanze morali vuote, perché private del loro significato originale: la persona di Gesù Cristo.
Si pensi, per esempio, al segno del crocifisso che condensa la fede cristiana; esso continua ad essere presente nella cultura occidentale, ma, svuotato del suo significato originale, si riduce a puro oggetto ornamentale oppure ad occasione di schieramenti ideologici. Naturalmente il discorso non va nella direzione di eliminare il segno della croce nella nostra cultura, ma piuttosto nella direzione opposta, che è quella di mantenerlo, rafforzando, però, il significato di cui è espressione. Lottare in difesa di alcuni segni cristiani, dimenticando il contenuto che li rende autentici, rischia di produrre inutili divisioni e contrapposizioni. La loro difesa dev’essere un’occasione perché da essi si può risalire al fondamento che li rende significativi: Cristo.
La preoccupazione più urgente, dunque, non riguarda la salvaguardia dell’ethos, ma l’annuncio del kerigma, cioè di Gesù Cristo, che nella sua persona, nella sua parola e nella sua esistenza intera incarna e dona una vita autenticamente umana. Questo non risolve il problema di come fare e quali strategie pastorali adottare perché la fede in Cristo diventi significativa per la vita degli uomini e delle donne di oggi, certamente diversa dai tempi di S. Paolo. La risposta non può venire dalla sola teologia morale, ma chiama in causa anche altre competenze, come, per esempio, la teologia pastorale, la catechesi e la spiritualità. Nondimeno, anche la teologia morale può fornire alcuni aiuti, oltre a quanto già accennato.
In particolare, si pensa all’importanza dell’esperienza, come elemento indispensabile per ognuno che voglia aderire all’annuncio della fede cristiana. Una delle caratteristiche dell’esperienza consiste nel fatto della sua unicità: il fatto che la genera può essere lo stesso per molteplici persone, ma il modo con cui esso viene percepito (esperienza) rimane unico e mai trasmissibile allo stesso modo. Si può raccontare, ma non farlo vivere come proprio ad un’altra persona. La narrazione della propria esperienza di Cristo può rappresentare un modo possibile per stimolare l’avvicinamento a lui da pare di chi l’ascolta. Anche se non si può ridurre l’adesione di fede all’esperienza personale dell’evangelizzatore, quest’ultima può rappresentare un invito a chiunque per vivere come proprio l’evento che l’ha suscitata.
Un secondo aiuto che la riflessione teologica morale può offrire al modo di proporre la fede in Gesù e l’ethos che ne consegue è la riscoperta autentica della sequela Christi, cioè del discepolato cristiano. Talvolta, nella storia, si è interpretata la sequela di Gesù come se implicasse l’esigenza di abbandonare e negare la propria personalità per imitarlo. Certo, la sequela comporta una rinuncia radicale, ma questa consiste nella rimozione di quegli elementi che impediscono la realizzazione piena della nostra umanità, in una parola del peccato, che chiudere il peccatore in sé stesso e gli impedisce ogni forma di relazione di dono. La sequela di Gesù apre la vita del cristiano e lo pone in grado di interpretare e realizzare in modo del tutto originale, cioè secondo il genio di ciascuno, l’intenzionalità profonda del Maestro, che è rappresentata dall’amore. E l’amore del cristiano, se non è onnipotente come quello divino, è certamente totipotente, come le cellule staminali: può adattarsi e specializzarsi per rispondere alle esigenze più diverse. Per questo, l’amore per definizione e per costituzione interna è relazione di dono, perché continuamente crea e ricrea ponti interrotti. È originale, perché il discepolo non fotocopia o clona il Maestro, ma ne interpreta l’intenzionalità a partire dal proprio genio e dalle proprie caratteristiche personali. È liberatorio, perché rompe la dittatura di un’autonomia intesa male perché concepita come autoreferenziale, senza relazione e, perciò, concretamente vissuta come solitudine, con l’esito di imprigionare la persona in una sorta di autismo che la rende sola in una folla di soli. Forse occorre relativizzare l’enfasi sull’ethos ed enfatizzare la figura di Cristo attraverso la narrazione che ne fa il vissuto del credente, sintesi di profezia e testimonianza. Così l’anamnesi di Cristo nella vita del credente può diventare un antidoto all’amnesia della presenza di Cristo nella storia e vivificare l’ethos cristiano.
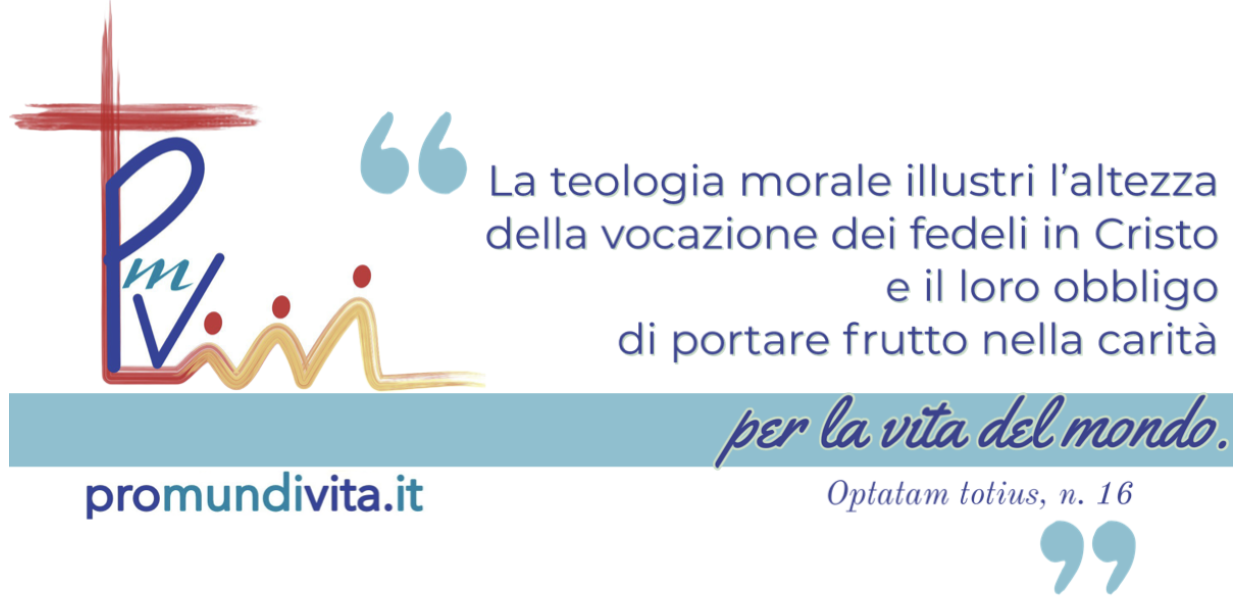




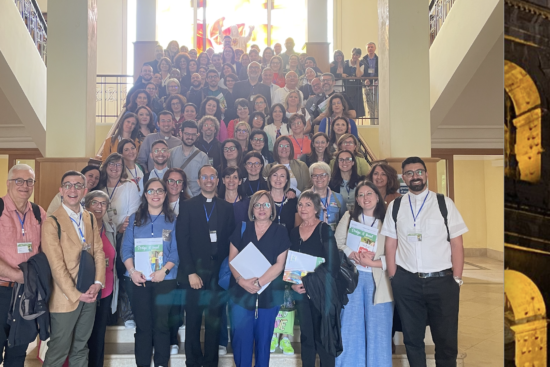

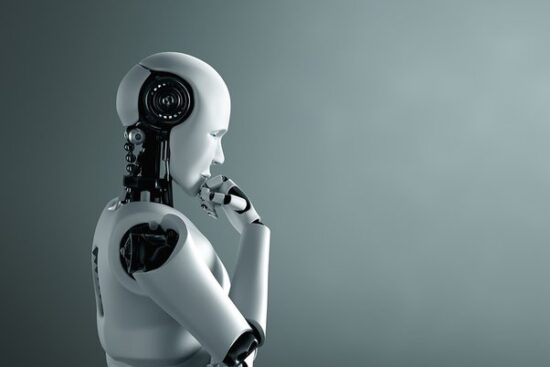
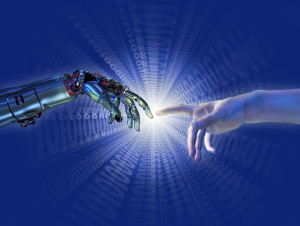

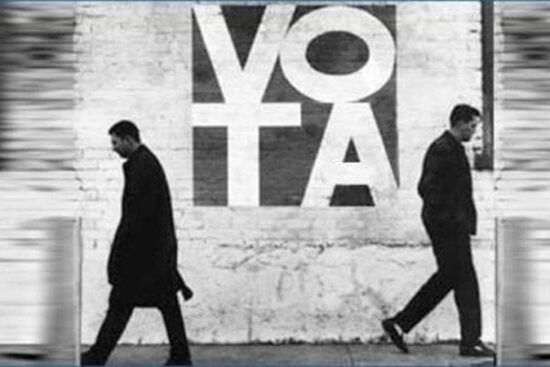


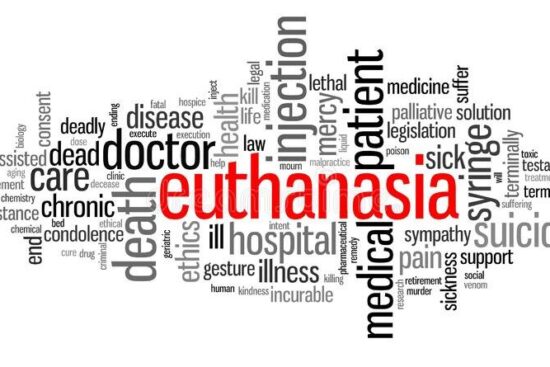

Lascia un commento