
Luigi Renna è Arcivescovo di Catania . Già docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica Pugliese, attualmente è Presidente della Commissione Episcopale CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e, al contempo, Presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia.

I primi passi del pontificato di Leone XIV ribadiscono con uno stile personale, l’impegno del papa e della Santa Sede per la pace, in modo particolare per la mediazione tra i Paesi in guerra. Nel discorso rivolto ai partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali, il papa ha indicato una linea chiara, che si muove tra la volontà personale di mediare e il coinvolgimento di un soggetto – la Santa Sede – che ha il volto della Segreteria di Stato e della fitta rete delle Nunziature presenti nel mondo: «Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace». Torna in maniera esplicita il ruolo della Santa Sede, che in molte situazioni ha condotto delle trattative pazienti e silenziose, che hanno intrecciato relazioni con i Capi di Stato e i loro diretti collaboratori.
Una visione
L’azione di promozione della pace della Chiesa parte da una visione in cui si mettono insieme vari elementi, che nella definizione sintetica del Compendio della Dottrina sociale sono tutti contemplati: «La pace non è semplicemente assenza di guerra e neppure uno stabile equilibrio tra forze avversarie, ma si fonda su una corretta concezione della persona umana e richiede l’edificazione di un ordine secondo giustizia e carità». (Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 494). L’unicità del magistero ha una sua autorevolezza universalmente riconosciuta, soprattutto su questioni nella quale fornisce uno sguardo etico alto e disinteressato rispetto agli interessi economici dei vari Paesi: si pensi alla ampia eco suscitata dalla Laudato sì e dall’attenzione focalizzata sulla dimensione etica dell’uso dell’Intelligenza Artificiale. Il magistero pontificio ogni anno viene arricchito sul tema dai messaggi del 1° gennaio, che danno l’opportunità di mantenere alta l’attenzione non solo sul tema della pace, ma anche su tutto quanto ad essa è connesso. L’insistenza sui temi della salvaguardia del creato e sulla democrazia hanno avuto interventi che possiamo definire complementari, in numerose dichiarazioni e in una esortazione apostolica, la Laudate Deum, scritta nel 2023 in prossimità della COP 28 di Dubai. Il “nutrimento” di ogni azione sociale della Chiesa è la dottrina sociale, costantemente aggiornata, anzi essa stessa azione che trasmette un pensiero e delinea orizzonti di pace, nei quali non sono assenti lo sviluppo dei popoli e la solidarietà tra le nazioni.
Un’azione plurale
Ad una visione così ampia corrisponde un’azione plurale, ricca di soggetti tra loro convergenti. Non bisogna dimenticare che l’azione della Santa Sede insiste su vari soggetti che convergono nell’unica direzione di costruzione della pace nella giustizia: quello del Dicastero della carità, che dà risposte immediate ai bisogni delle popolazioni stremate dalla guerra, manifestando quella prossimità che vede intervenire tempestivamente l’Elemosiniere pontificio con azioni caritative concrete. C’è l’azione che vede impegnato il Dicastero per lo sviluppo integrale dell’uomo, nel quale si fa una grande opera educativa e di promozione volta a sradicare i presupposti o le conseguenze dei conflitti. C’è l’azione dei Dicasteri per il Dialogo interreligioso e per l’Ecumenismo, che svolgono un lavoro di costante dialogo fra fedi e Chiese, preparando il terreno al dialogo fra i Paesi. Nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede del gennaio 2023, papa Francesco ribadiva: «…il compito della diplomazia è proprio quello di appianare i contrasti per favorire un clima di reciproca collaborazione e fiducia per il soddisfacimento di comuni bisogni» (Francesco, Discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede del 9.1.23). La Curia romana, lungi dall’apparirci una struttura burocratica e caduca, ha dei compiti che sono al servizio dell’annuncio del Vangelo e della concordia tra i popoli, così come ben delineato nella Costituzione che l’ha riformata, la Praedicate evangelium del 2022. C’è l’azione preziosa della Segreteria di Stato, soprattutto nella sezione degli affari generali, che non solo tratta le questioni concordatarie, ma anche quelle internazionali. Essa non si arroga il protagonismo delle trattative, come potrebbe fare qualunque Paese, ma richiama all’importanza degli organismi internazionali, perché solo essi possono assicurare un dialogo costante. In occasione della conferenza “L’Europa e la guerra. Dallo spirito di Helsinki alle prospettive di pace” del 13 dicembre 2022, il cardinal Parolin ribadì il pensiero della Fratelli tutti di Francesco sul ruolo del diritto: «Bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato e ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale […] La Carta delle nazioni unite, rispettata ed applicata con trasparenza e sincerità, è un punto di riferimento obbligatorio e un veicolo di pace».
Principi sempre “aggiornati”
Credo che tra i testi più significativi che richiamano al quadro di principi della Dottrina sociale nell’ambito dell’azione della Chiesa, ci sia la ripresa dei quattro beni fondamentali della Pacem in terris, richiamati alla memoria da Francesco nel succitato discorso diplomatico accreditato presso la Santa Sede, due dei quali (verità e giustizia), sono presenti anche nel primo discorso di papa Leone XIV allo stesso corpo diplomatico. I quattro beni fondamentali sono: la verità, la libertà religiosa, la giustizia, la solidarietà. La verità a cui si fa riferimento è quella del riconoscimento di diritti umani; la libertà religiosa è opportunità di dialogo fra popoli e culture diverse; la giustizia crea le basi del dialogo e dell’uguaglianza tra i Paesi, con una azione multilaterale; la solidarietà che nel nostro tempo si traduce in attenzione ai migranti, al lavoro, alla cura della casa comune. I principi enunciati da Giovanni XXIII sono stati “aggiornati” con la sollecitudine per le questioni sociali emergenti, cause esse stesse di conflitti di varia natura, per cui oggi abbiamo anche l’opzione preferenziale per i poveri e l’azione dei movimenti popolari, che in iniziative come Economy of Francesco hanno messo in comune le loro buone prassi.
In definitiva, la Dottrina sociale della Chiesa, a servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa (cf. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 41) non è disgiunta dalle buone prassi e dall’azione che vede convolto tutto il popolo di Dio: i pastori, gli organismi della Santa Sede, i movimenti di opinione che, come avrebbe detto papa Francesco, “fanno rumore”. Perché tutti, come ha affermato papa Leone XIV, devono «partecipare attivamente e creativamente a questo esercizio di discernimento, contribuendo a sviluppare la Dottrina sociale della Chiesa insieme al popolo di Dio, ascoltando e dialogando con tutti» (Leone XIV, Discorso ai membri della Fondazione Centesimus annus pro Pontifice del 17.5.2025).
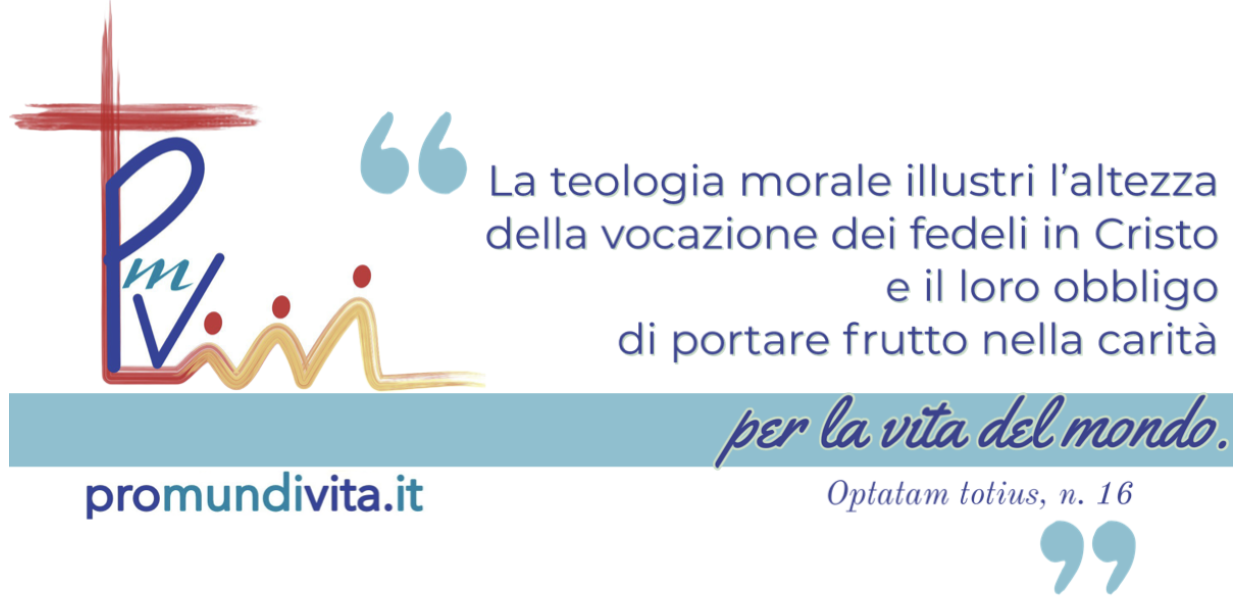




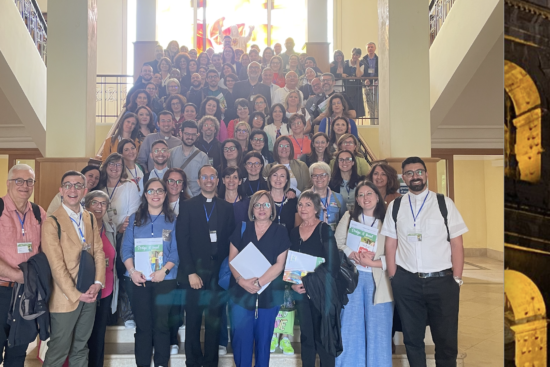

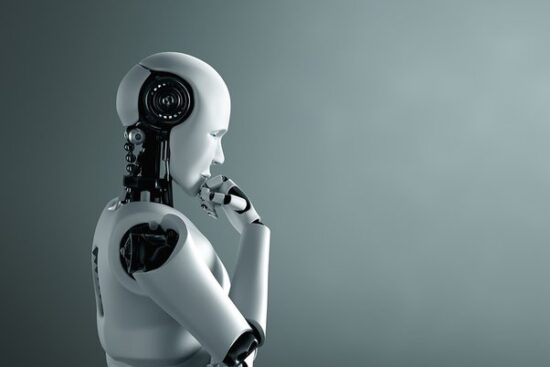
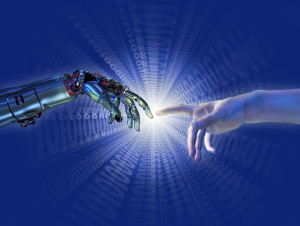

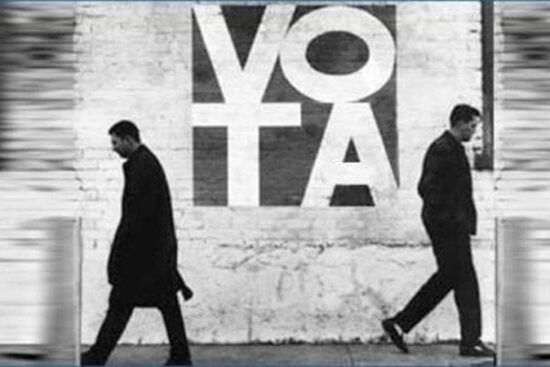


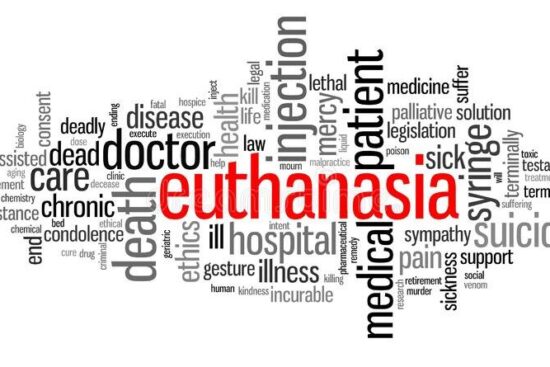

Lascia un commento