
Dopo la prima risposta di Gabriele Raschi alla domanda di fra Francesco Maddalena, la prima reazione è affidata a Letizia Tomassone. Pastora valdese, docente di Studi femministi e di genere presso la Facoltà Valdese di Teologia, si interessa in particolare di teologie ecofemministe e di dialogo interreligioso. Tra le pubblicazioni: Figlie di Agar. Alle origini del monoteismo due madri (a cura di) (Effatà 2014); Crisi ambientale ed etica. Un nuovo clima di giustizia (Claudiana 2015); «Dialogo interreligioso e femminismi», in Protestantesimo 72(2017)4, 369-377.

“Ingiunzione di maschilità” la chiama Rita Laura Segato. È quella condizione (sub-) culturale di violenza che propone ai maschi la violenza e il possesso dell’altro, dell’altra come unica forma di affermazione di sé.
Riguarda i maschi, soprattutto i più giovani, perché attraverso i social e le piattaforme digitali ne modella il modo di essere. E anche quando sentono in modo diverso dentro di sé quella maschera di aggressività e affermazione resta un ancoraggio sicuro, un modo premiato e accettato socialmente e che restituisce privilegi e potere. Anche quando crea un pozzo profondo e angosciante di solitudine interiore.
Spesso le generazioni passate hanno dovuto combattere con l’ordine morale precedente, per distaccarsene e vivere con libertà. Questo conflitto ha dato forma alle lotte femministe, ma prima ancora alla Resistenza contro il fascismo. Ha creato spazi di libertà in cui far crescere forme di relazioni improntate dalla cura e dall’amore, dal senso di responsabilità per qualcun altro e per la società stessa.
Ma oggi viene a mancare quel conflitto con un altro ordine morale trasmesso dall’educazione famigliare o anche religiosa, quella radice genealogica che non fa sentire soli nel mondo. Sembra di vedere oggi generazioni di persone giovanissime che non hanno neanche l’idea di dover combattere contro un ordine morale interiorizzato. Tutto è stato eliminato e resta solo quell’ingiunzione di maschilità e quell’ordine basato sul prendere a proprio vantaggio tutto ciò che ci sta intorno, compresa la vita degli altri.
Adolescence (la serie Netflix) racconta molto bene le contraddizioni, i dolori e le rigidità che si impongono sui corpi e sulle menti dei ragazzi giovani, soprattutto sui maschi, educati fin da piccoli a non piangere, essere forti, dominare o non mostrare fragilità. È uno spaccato potente della maschilità tossica: quell’insieme di modelli culturali che fanno male sia a chi li subisce che a chi li incarna.
In realtà, nella tradizione biblica, il pianto, la fragilità, la richiesta di aiuto non sono mai visti come “debolezza”, ma come segni della piena umanità (penso alla storia di Davide, ai Salmi, a Gesù che piange su Gerusalemme). Come scrive Paolo: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,10)
È come se avessimo perso le radici evangeliche della costruzione e della maturazione della persona.
Sicuramente questo è un fallimento dei discorsi religiosi, che hanno continuato a proporre l’amore reciproco e l’umiltà come vie di accesso alle relazioni ma hanno continuato a vivere pratiche di potere. Io credo che il fallimento sia probabilmente dovuto alla contraddizione fra la rappresentazione gerarchica mostrata dalle chiese che hanno oscurato le parole di Gesù contro le gerarchie e contro le forme di dominio. Il discorso evangelico ha perso efficacia perché è rappresentato troppo spesso da apparati e si mostra lontano dalla vita, ambiguo e normativo rispetto alle relazioni.
Gli scandali di abusi sessuali e di uso del potere per ottenere favori hanno poi disgustato e allontanato le persone dalle chiese, spesso allontanandole anche dal centro focale del vangelo.
Mi pare che abbiamo di fronte due strade da percorrere.
La prima è quella di restituire valore alla vulnerabilità e alle ferite che fanno crescere. Di ritrovare una umanità che sa prendersi cura, che non mette al centro il valore del consumo ma quello dell’amore che non consuma.
Si tratta quindi di ritrovare il senso di diventare adulto, maschio o femmina, attraverso il prendersi cura di sé, delle proprie parti fragili, senza indurire e mascherare chi si è.
La seconda è quella di ridare respiro al conflitto morale, facendo diventare forte un’etica della tenerezza e della giustizia. Come indica Elena Pulcini, tra altri, cura e giustizia vanno insieme, devono andare insieme.
Per non confinare la cura all’identità femminile che accoglie, ma farla diventare un modo di stare al mondo. E per non rendere la giustizia un concetto astratto e lontano dalla vita, facendola invece diventare sguardo sul mondo, pratica di relazione. Nella sua visione, la cura deve diventare un principio politico e sociale, capace di trasformare anche il modo in cui intendiamo la giustizia.
Pulcini parla della vulnerabilità come concetto centrale del costruire relazione. Vulnerabilità che si sperimenta proprio su quel confine tra vita e morte a cui la violenza espone. Perché diventi un punto di svolta non possiamo attendere gli eventi estremi delle guerre, è necessario lavorare sula coscienza morale, a partire da questi valori tradizionalmente opposti – cura e giustizia – che però nel Dio biblico vanno assieme. Misericordia e giustizia sono infatti l’uno il bilanciamento dell’altro. Quante volte Dio viene definito in questo modo: «Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà».
Portare i giovanissimi a praticare cura del mondo, di sé stessi e degli altri significa abituarli alla cura, al riconoscimento della propria e altrui vulnerabilità. Non è un atto “sentimentale” o “debole”, ma un atto che costruisce comunità solidali e relazioni sane.
Un’etica che intreccia cura e giustizia potrà spezzare la catena della violenza e della sopraffazione, aprendo la strada a una maschilità nuova, capace di custodire la vita invece di dominarla e violentarla.
È l’etica della vulnerabilità che sta alla base della pratica non violenta che può aiutare a contrastare l’ingiunzione di maschilità così ben rappresentata nella serie di Netlix Adolescence. La serie ci pone di fronte alla domanda: che idea di maschilità stiamo trasmettendo?
La maschilità tossica non è l’essere maschio in sé, ma l’obbligo a incarnare modelli rigidi: non piangere, non avere paura, dominare sugli altri, anestetizzare i sentimenti. È un modello che ferisce — prima di tutto — i maschi stessi. È il terreno su cui nascono i femminicidi.
Adolescence ce lo mostra senza sconti: i protagonisti spesso si trovano soli, incapaci di comunicare il loro dolore, addestrati fin da piccoli a credere che la vulnerabilità sia una vergogna, che l’empatia sia un cedimento.
Questo non riguarda forse anche i maschi adulti? Spesso soli e con amicizie che mancano di un confronto profondo. Quando viene a mancare la relazione di coppia, spesso l’unica in cui hanno potuto mostrare veramente la propria vulnerabilità prevale la chiusura e la violenza.
Segato analizza la struttura economica in cui viviamo, quella predatoria nei confronti della natura che riduce le persone a consumatori ma anche a merci da cui estrarre i preziosi dati e a volte, nelle situazioni più estreme di guerra o di tratta, gli organi.
Come pastora protestante e credente femminista, sento l’urgenza di rileggere queste ferite alla luce della Scrittura.
Forse la Scrittura con le sue narrazioni può ancora fornire uno sfondo che contrasti la prevaricazione dell’uno sull’altro. Ma le grandi narrazioni non bastano se non si ritrovano gli spazi di condivisione e dialogo. Quelli in cui l’altro o l’altra diventano il pozzo a cui attingere l’acqua per la propria sete. Quelli dove insieme si cresce e le emozioni, le amicizie, la verità dell’uno e dell’altro fioriscono.
A cosa servono serie televisive come Adolescence? Hanno uno scopo? Forse il loro intento non è quello di dar forma al modello maschile tossico e aggressivo, ma quello di mettere gli spettatori di fronte a una realtà di violenza crescente che si vorrebbe ignorare.
Le immagini di guerra reale e distruzione che affollano i nostri schermi anestetizzano i nostri sensi, ci rendono indifferenti. I cristiani di Palestina chiedono alle chiese occidentali perché tacciono di fronte a tanta distruzione!
Adolescence è solo un altro modo di farci abituare alla violenza, oppure può portarci fuori, verso relazioni diverse, anche tra adulti e adolescenti? Scegliamo la nostra risposta, restituendo valore alle relazioni in presenza, allo spazio occupato dai corpi, agli odori, alle grida di dolore o di piacere che ci possono arrivare non attraverso le cuffiette ma dall’interazione e dalla tenerezza dei corpi.
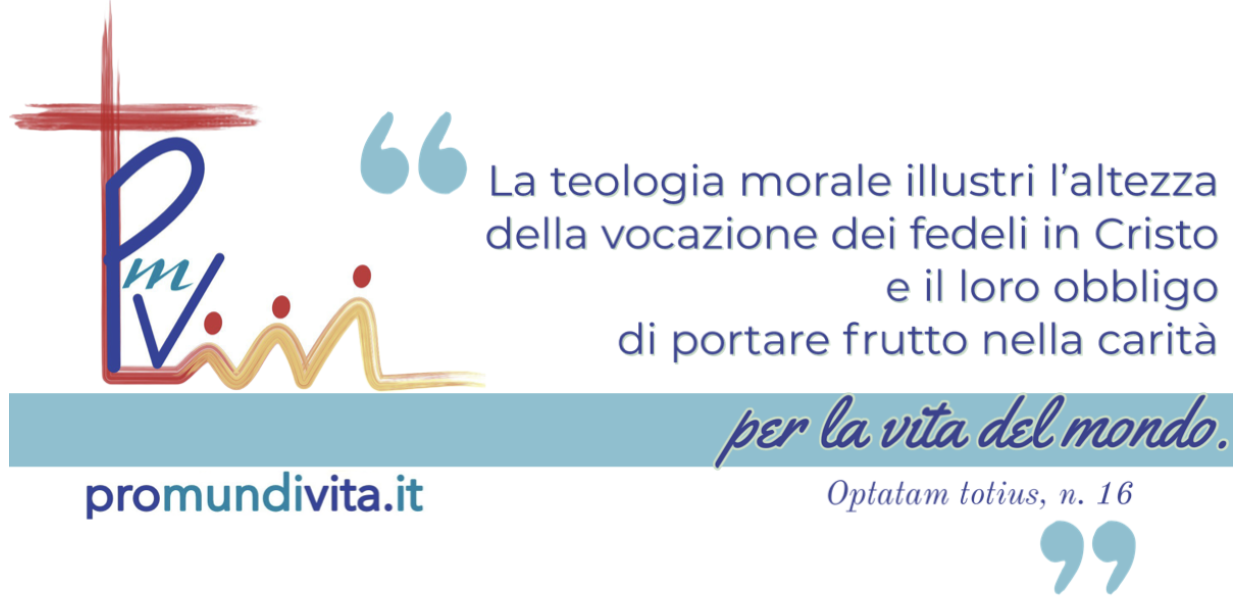




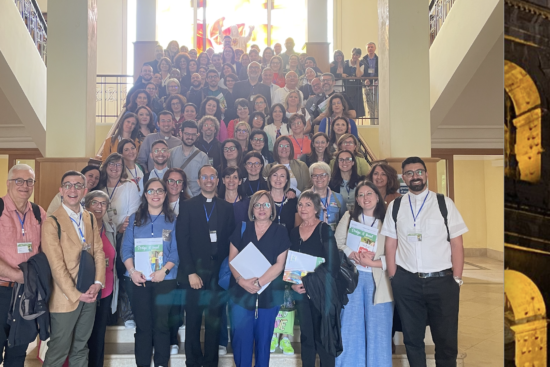

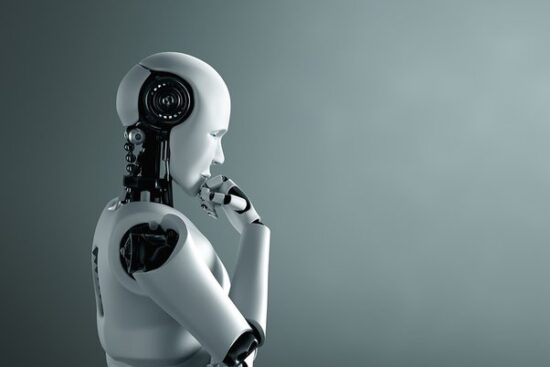
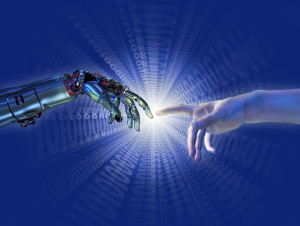

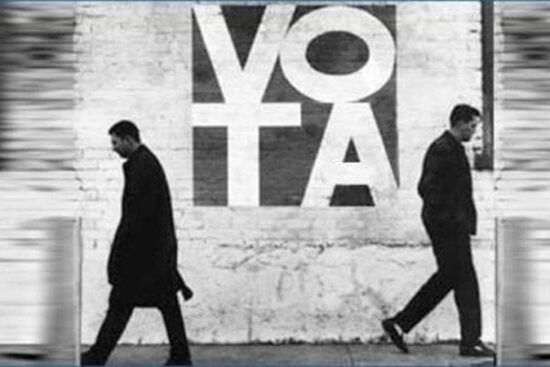


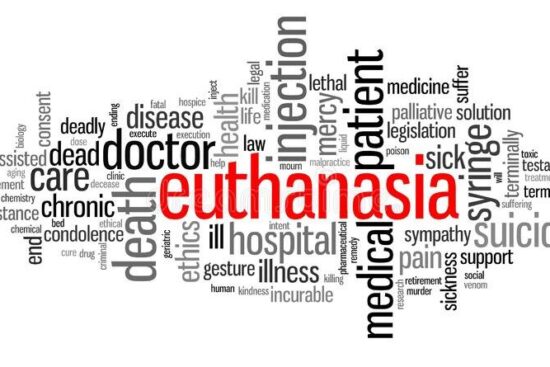

Lascia un commento